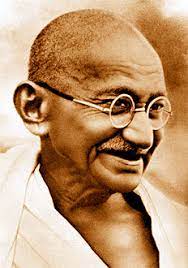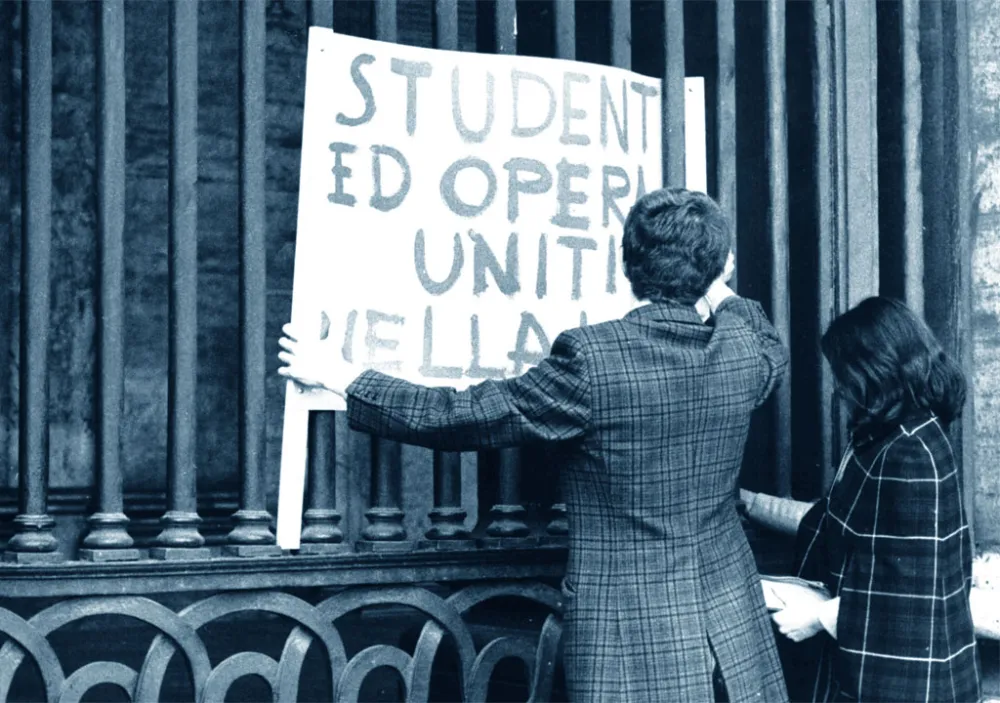PAGINE
Rubrica di critica recensioni anticipazioni
by Augusto Cavadi
“Il mio personale rapporto tra violenza e non violenza inizia negli anni Settanta (…). E’ il tempo della grande contestazione (…). Iniziato che ero un timido ragazzino, curioso di capire il mondo entro i venti di rivolta che lo animavano, e concluso da adulto nelle dure lotte del Settantasette col ruolo riconosciuto di leader del movimento studentesco e col soprannome, sicuramente significativo, di <<Molotov>>”: così, sin dalla prima pagina, si presenta Antonio Minaldi, autore del recente Gandhi ad Auschwitz. Elogio della Nonviolenza (e sue problematiche), Multimage, pp. 99, euro 10,00.
“L’adesione all’ipotesi della lotta armata come strategia politica era lo spartiacque tra noi che ci consideravamo i veri rivoluzionari e coloro che avevano tradito i vecchi ideali, consegnandosi al nemico con sbiaditi discorsi riformisti” (pp. 7 – 8). Da allora passa, non invano, mezzo secolo: intreccio di altre esperienze politiche, di viaggi per il mondo, soprattutto di letture e di riflessione. L’esito, abbastanza recente, di questo itinerario é l’adesione “alla teoria e alle pratiche della Nonviolenza” (p. 9), non solo come “scelta di vita” ma anche come “strumento privilegiato, costitutivo e strategico, di una scelta politica non qualsiasi, ma ‘rivoluzionaria’, rivolta cioè alla capacità fattuale di abbattere un potere dominante, violento e armato, votato al sopruso e alla guerra” (p. 10).
Trovo molto significativa questa testimonianza del coetaneo Minaldi e – devo confessare – anche confortante per quanti, sin dal Sessantotto, ci siamo convinti che la società cui dedicare la totalità delle nostre energie fosse di “liberi, uguali e fraterni” e che avvicinarvisi con “dittature” più o meno terroristiche fosse un modo per allontanare la méta (dal momento che senza “libertà” e “fraternità” tutto ciò che si ottiene è la sostituzione delle ineguaglianze economiche con le ineguaglianze di potere, pervertendo – per citare Ignazio Silone – la dittatura del proletariato in dittatura sul proletariato ).

Da allora infatti la nostra posizione di “amici della Nonviolenza” che non hanno la sfrontatezza di qualificarsi come “nonviolenti” é stata ed è bersaglio di tiri incrociati: da parte dei “duri e puri” che, di frazionismo in frazionismo, sono arrivati alla divisione dell’atomo e da parte dei “realisti” ben inseriti nello status quo (spesso ex-rivoluzionari pentiti) che ci accusano di ingenuità “utopistica”.
Ciò premesso e chiarito, mi pare doveroso aggiungere che il lodevole scritto di Minaldi non é privo di sviste storiche né di lacune né di passaggi molto opinabili.
Quando parlo di sviste mi riferisco ad asserzioni come: all’epoca di Marx “il concetto di Nonviolenza, così come la potenza del femminile, come strumenti di lotta politica capaci di incidere nei rapporti di forza non avevano ancora fatto il loro ingresso nella storia” (p. 63). Senza risalire lontano per millenni sino a Socrate, Buddha, il Taoismo, Gesù e neppure per secoli sino a Erasmo da Rotterdam , Voltaire e Kant (autori di cui si devono riconoscere almeno semi rilevanti di rifiuto della logica della gestione violenta dei conflitti) mi sembra opportuno notare che Marx (nato nel 1818) è stato un contemporaneo di Henry David Thoreau (nato nel 1817) e di Lev Tolstoj (nato nel 1828): la Nonviolenza, “antica come le montagne” (Gandhi), è stata davvero a disposizione di chi ha avuto il desiderio di vederla!
Un’altra svista non secondaria per rilevanza mi pare l’identificazione di “aggressività” (che è un dato fisiologico, genetico, necessario alla sopravvivenza del soggetto) e “violenza” (che è un dato patologico, culturale, nocivo alla sopravvivenza dell’individuo e della sua specie): la violenza e la nonviolenza sono due modi alternativi di gestire, di canalizzare, di istituzionalizzare l’aggressività. Dunque non è esatto affermare che “violenza e Nonviolenza ci appartengono per natura” (p. 70) dal momento che, invece, tendenze innate (o acquisite nei millenni di storia evolutiva) sono – “in un continuo mediarsi” (ivi) – la pulsione aggressiva alla competizione e la pulsione alla cooperazione solidale.
Una delle conseguenze di questa (inesatta) identificazione di “aggressività” e “nonviolenza” mi pare sia l’affermazione secondo cui – posto che “la guerra” sia “un dato emblematico dei modi che in ogni epoca storica hanno caratterizzato la violenza” (p. 73) – “lo scontro armato e le migrazioni violente e predatorie dei popoli debbano essere considerati come dati senza i quali la storia umana non si sarebbe neppure resa possibile” (ivi). Ma è davvero così? Se si concede questa retrospettiva allo storicismo hegeliano non si dovrebbe condividere la prospettiva della “fine della storia” qualora l’evoluzione umana ci portasse a escludere come un tabù il ricorso alla guerra? Direi che la storia umana non sarebbe stata possibile nel passato e non lo sarebbe nel presente e nel futuro senza conflitti, senza divergenze di sentimenti e di umori, senza dialettica di idee e di interessi; ma non senza scontri bellici (o comunque violenti, tesi all’annichilimento o per lo meno alla sottomissione dell’altro). Senza le guerre ci sarebbe stata un’altra storia, non l’impossibilità radicale del configurarsi di una storia.
 Questa interpretazione non esclude che, a posteriori, si possa constatare che le guerre – in sé non necessarie né proficue – abbiano prodotto non “solo morti e distruzioni”, ma anche “forme di scambio commerciale e culturale”(ivi): si tratta, appunto, di “effetti di socializzazione secondaria” (ivi) che si sarebbero potuti ottenere, come si spera possa avvenire quando saremo progrediti a un livello più alto di civilizzazione, anche senza guerre.
Questa interpretazione non esclude che, a posteriori, si possa constatare che le guerre – in sé non necessarie né proficue – abbiano prodotto non “solo morti e distruzioni”, ma anche “forme di scambio commerciale e culturale”(ivi): si tratta, appunto, di “effetti di socializzazione secondaria” (ivi) che si sarebbero potuti ottenere, come si spera possa avvenire quando saremo progrediti a un livello più alto di civilizzazione, anche senza guerre.
Tra le lacune mi sembra evidente l’assenza di riferimenti a tesi che ormai sono ritenute fondamentali per qualsiasi delle possibili versioni della nonviolenza, quali ad esempio la dicitura satyagraha (“insistenza della verità”) in coppia, se non in sostituzione, di ahimsa (“non nocenza”). Infatti molti interrogativi che l’autore si pone non avrebbero, a mio sommesso avviso, ragion d’essere se si chiarisse che la proposta gandhiana (e non solo) non è soltanto “negativa” (astensione dall’esercizio della forza fisica e militare) ma anche, e soprattutto, “positiva” (tentativo di raggiungere la coscienza dell’avversario affinché accetti di gestire il conflitto senza ricorso alle armi). Questa mia osservazione specifica può valere, più ampiamente, per l’intero libro: da un neofita mi sarei aspettato almeno qualche riferimento alla letteratura primaria e secondaria della ormai sterminata bibliografia sulla nonviolenza dove molte “problematiche” che la concernono sono state tante volte focalizzate e (per quanto possibile in un campo così accidentato) risolte.
Tra i passaggi opinabili segnalerei, innanzitutto, le righe in cui – più volte – si contrappone l’opzione della Nonviolenza al “diritto di resistenza” (p. 47). Qui sarei molto più chiaro: la Nonviolenza o è un modo di praticare la resistenza o non serve a nulla. Dunque la vera contrapposizione è fra il “diritto alla resistenza, anche nelle sue forme estreme che possono prevedere l’uso della lotta armata” (ivi) e il “diritto di resistenza” con tutte le molteplici tecniche elaborate e sperimentate sul campo dalla tradizione nonviolenta. Personalmente sono convinto (per quel che ne so in sintonia con i padri fondatori della Nonviolenza) che reagire con la violenza a una ingiustizia palese (ad esempio l’invasione del proprio territorio da parte di un esercito straniero) sia preferibile all’inerzia passiva; ma che molto preferibile alla reazione violenta sia la resistenza nonviolenta da parte di una popolazione preparata da anni a simili eventualità (e dunque allenata agli scioperi, i boicottaggi, la disobbedienza civile, la renitenza all’arruolamento forzato etc.: va in questa direzione la richiesta avanzata da anni dal Movimento Nonviolento dell’istituzione di un “Ministero della pace” che preveda l’addestramento di un vero e proprio ‘esercito’ per la “Difesa popolare nonviolenta”). Se questo non si afferma con chiarezza si può dare l’impressione che la Nonviolenza sia un’ottima soluzione nelle situazioni ‘moderate’, ma vada messa nell’armadio in attesa di tempi migliori quando il gioco si fa serio.
Queste incertezze nell’esposizione di Minaldi riflettono, probabilmente, un’impostazione di fondo per lo meno problematica: la dicotomia fra “etica” e “politica” e l’attribuzione della scelta nonviolenta essenzialmente alla prima sfera. In tale scenario, infatti, è inevitabile che certi principi etici – in sé intoccabili – vadano poi declinati nella prassi storica concreta con elasticità. Ma è una prospettiva corretta?