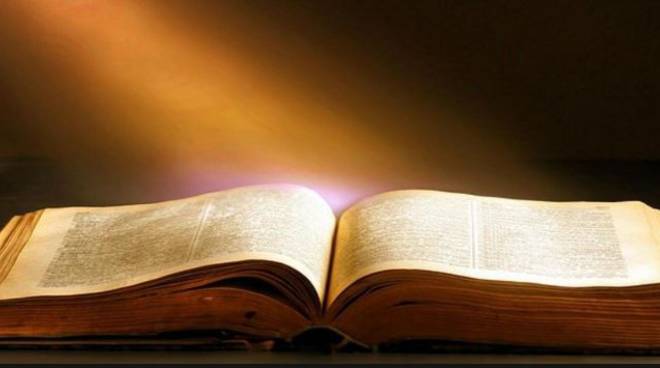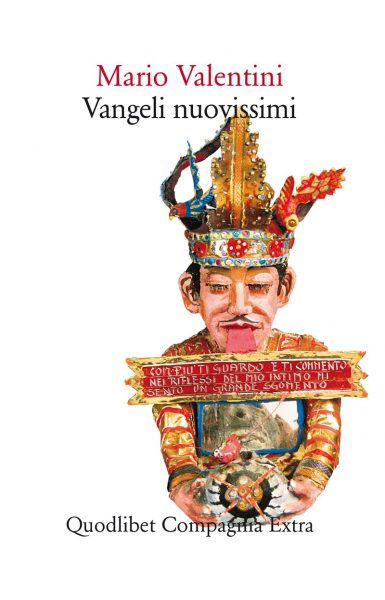Zerozeronews è una realtà editoriale web, originale e inedita, ideata e diretta da Gianfranco D’Anna, che si rivolge a un vasto target istituzionale, socialmente ed economicamente trasversale. Le notizie dietro le notizie: anticipazioni e analisi sono gli obiettivi essenziali delle news istituzionali, politiche, economiche, sociali e internazionali
Contact us: zerozeronews.it@gmail.com
This Blog does not represent a newspaper as is updated without any periodicity, it cannot, therefore, be considered an editorial product pursuant to law n. 62 of 7/03/2001. The images included in this blog are mostly taken from the Internet. If their publication violates any rights copyright, please let us know and they will be removed immediately
CHI SIAMO
Direttore: Gianfranco D'Anna
mail: gfdanna@yahoo.com
mobile: 3319619046
REDAZIONE
Zero Zero News
Direttore Gianfranco D’Anna
Questo Blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità, non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001. Le immagini inserite in questo blog sono tratte in massima parte da Internet. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarcelo e saranno subito rimossi.