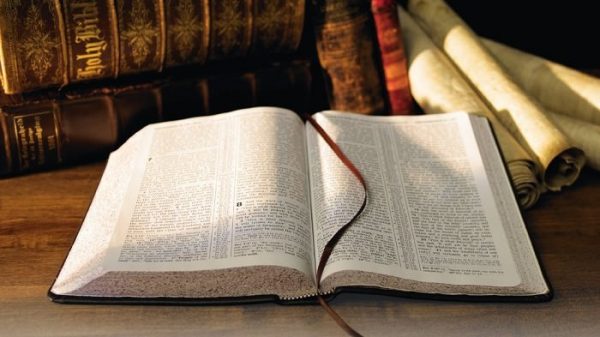PAGINE
Rubrica di critica recensioni anticipazioni
by Augusto Cavadi
Pedagogia della libertà. Maurizio Baldino ha speso la sua vita nella scuola, da maestro elementare a dirigente scolastico. In quiescenza dal punto di vista giuridico, non lo è esistenzialmente e la sua perdurante passione per l’educazione si è tradotta nel volume Urge la pedagogia. L’emergenza educativa esige la pedagogia della libertà, Brenner, Cosenza 2019, pp. 256, euro 20,00.

Le sue pagine vanno lette con particolare attenzione per non equivocare sulla prospettiva dell’autore che, da una parte, si esprime da cattolico, convinto con don Luigi Giussani (fondatore di “Comunione e liberazione”) che la fede consista nel rivivere eventi storici fondativi (come l’esodo dall’Egitto del popolo ebraico prigioniero e la pasqua del “divino” Gesù di Nazareth); ma, con altrettanta schiettezza, contesta la teoria pedagogica dello stesso Giussani (ripresa quasi alla lettera da Benedetto XVI) secondo la quale educare significherebbe plasmare un giovane secondo il modello “prestabilito” del cristiano virtuoso. A giudizio di Baldino, invece, la pratica educativa ha “il compito primario di fare l’uomo autenticamente libero, il quale, solo da uomo autenticamente libero, con la sua libertà qualificherà il suo essere del valore aggiunto costituito dall’essere cristiano” (p. 61).
Come è facile intuire, una prospettiva del genere sarà spiazzante sia per i ‘laici’, che la troveranno pericolosamente confessionale, sia per i ‘cattolici’ ortodossi, che la troveranno insopportabilmente libertaria, irenica.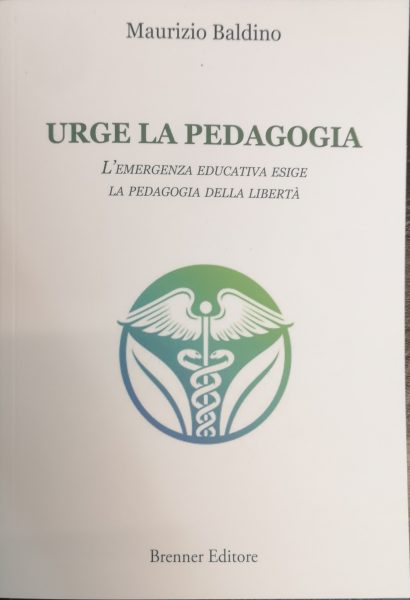
Condivido il modo in cui l’autore presenta il rapporto teologia/pedagogia: nell’esercizio dell’educatore (anche se personalmente credente) il primato intenzionale spetta alla pedagogia, come arte di favorire nei più giovani la libertà, e la teologia deve rinunziare alla “pretesa di essere la madre di tutte le scienze” per “servire l’uomo nel suo rapporto con se stesso, con i suoi simili e con il divino” (se non vuole ridursi, come storicamente è avvenuto in questi due millenni, a “utile strumento del potere”) (p. 65). In caso diverso, torniamo – o restiamo – ai tempi in cui Pio IX implorava il re Vittorio Emanuele II di evitare il “flagello” dell’educazione obbligatoria (dal momento che ai ragazzi, e soprattutto alle ragazze, dei ceti meno abbienti basterebbe imparare un mestiere e recepire docilmente “la buona educazione paterna e l’istruzione religiosa”) (cfr. p. 72). Oppure ci infogniamo nelle polemiche attuali contro l’identità sessuale quale sommatoria di quegli elementi (sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento affettivo) che Baldino analizza in pagine particolarmente equilibrate e illuminanti (pp. 87 – 98).
Ciò che non condivido è la convinzione di Baldino che don Giussani o Joseph Ratzinger abbiano tratto conseguenze errate da premesse corrette. A mio parere, infatti, essi hanno tratto in maniera corretta conseguenze errate da premesse altrettanto errate. Entrambi, infatti, hanno predicato “un Cristianesimo come avvenimento storico rispetto al quale non si può rimanere neutrali” (p. 222), dimostrando così non di essere (come li ritiene Baldino) di “profonda cultura”, bensì d’ignorare la rivoluzione copernicana avvenuta negli ultimi cento anni e di leggere la Bibbia con gli occhiali del letteralismo fondamentalista pre-critico. Baldino non si spaccia mai per esperto di teologia e la sobrietà nell’esprimersi in un ambito disciplinare che non è il suo gli fa onore. Egli cita, con approvazione, Simone Weil (“La Chiesa ha portato troppi frutti cattivi perché non ci sia stato un errore all’inizio”), ma sembra identificare tale errore nell’intreccio della “dottrina” teologica con la “politica” (pp. 68 – 69), senza sospettare che già la dottrina dogmatica elaborata nei primi tre secoli costituisce il primo, radicale, tradimento dell’originario annunzio evangelico.
Poiché la sua ricerca è in progress sarebbe auspicabile che egli aggiornasse la sua informazione anche in questo campo, cominciando da testi propedeutici accessibilissimi come Cristiani nel XX secolo ? Una rilettura radicale del Credo del gesuita Roger Lenaers o Perché il cristianesimo deve cambiare o morire. La nuova riforma della fede e della prassi della Chiesa del vescovo episcopaliano John Shelby Spong.

Solo con teologie di questa altezza ha senso che la filosofia e le scienze umane (pedagogia inclusa) si misurino. Tutto il resto appartiene all’archeologia della storia della riflessione cristiana.