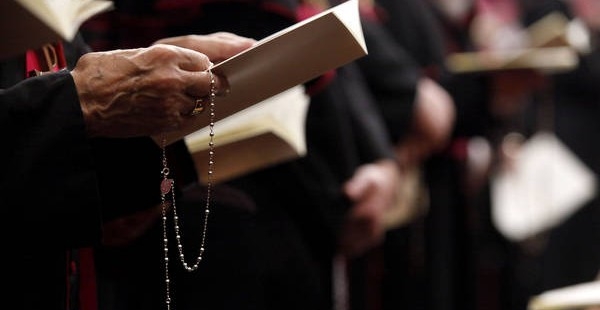PAGINE
Rubrica di critica recensioni anticipazioni
by Augusto Cavadi
In tutte le culture inchinarsi è un segno di reverenza, spesso anche di subordinazione. Nell’Italia meridionale – dove il senso della ‘comunità’, basata sui rapporti personali, prevale sul senso della ‘società’, basata sulle regole oggettive – esso possiede ancestralmente una forte valenza simbolica.
E’ facile intuire, dunque, quanto credito sociale guadagna un boss mafioso se la statua della Madonna o di un santo protettore, nel corso di una processione, si ‘inchina’ in segno di omaggio davanti la sua abitazione: nel linguaggio espressivo dei segni, equivale a farsi proclamare Dio. O qualcosa di molto vicino al divino.

Su questo fenomeno non mancano le documentazioni giornalistiche né i commenti occasionali di vari studiosi, ma solo in questi giorni esso è diventato oggetto di uno studio organico nel volume di Davide Fadda, L’inchino. Santi, processioni e mafiosi nel Meridione italiano (Di Girolamo, Trapani 2021, pp. 168, euro 20,00).
Il giovane autore è partito da due casi di studio (le processioni della Madonna delle Grazie a Oppido Mamertina e della Madonna del Rosario a San Paolo Bel Sito) e, con l’aiuto di alcuni esperti sui rapporti fra le chiese e le mafie (tra cui don Francesco Michele Stabile, Salvatore Lupo e Giancarlo Caselli), ha inserito questi due episodi di cronaca nel quadro complessivo della religiosità cattolica mediterranea e delle strategie attuate costantemente dalle cosche criminali per strumentalizzarla ai fini della propria legittimazione.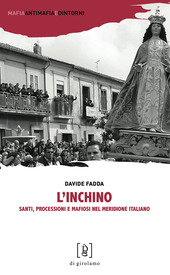
Tale strumentalizzazione risulterebbe disagevole se dovesse fare i conti con una Chiesa più fedele al messaggio originario di Cristo, più libera perché concentrata su principi di giustizia e di fraternità solidale; non – come invece avviene – con una chiesa “fortemente gerarchizzata”, diventata “una delle potenze indiscusse nel panorama politico europeo per quasi duemila anni” (p. 37).
Il quadro che viene restituito è variegato sia nel tempo che nello spazio: la storia scorre, per fortuna, anche sotto i ponti del Meridione italiano, così che in alcune cittadine le amministrazioni locali – in linea con la tradizione – chiudono un occhio (o tutti e due gli occhi); in altre, invece, anche per il coraggio personale di alcuni esponenti delle istituzioni civili e religiose, il disegno egemonico dei mafiosi viene smascherato, denunziato e smantellato. Già, il coraggio che – sostiene Fadda – “significa non solo staccarsi da una proposta sociale e culturale «sbagliata» ma non cedere, per quanto possibile, alla nostra paura principale, che è morire” (p. 146).
Le pagine di questo testo si leggono agevolmente, volutamente prive – come sono – di tecnicismi per gli addetti ai lavori. E andrebbero meditate da quanti occupano, nelle chiese cristiane e nelle varie articolazioni dello Stato democratico, ruoli di responsabilità: costituiscono una voce ‘laica’ che esorta, rispettosamente, a prevenire e contrastare i perduranti tentativi dei mafiosi di alimentare il consenso sociale a proprio favore non solo col ‘bastone’ delle intimidazioni ma anche con la ‘carota’ della devozione e della beneficenza.
Ovviamente, come tutte le esplorazioni pionieristiche, potrà essere corretto in alcuni passaggi, integrato in altri: ma, se riuscirà a rilanciare un sentiero di ricerca scientifica e pedagogica, avrà raggiunto l’obiettivo più prezioso.