PAGINE
Rubrica di critica recensioni anticipazioni
by Augusto Cavadi
La paura del Covid-19 e la virtù del coraggio. I filosofi si occupano sempre di tematiche meta-temporali: in alcuni casi seguendo un proprio percorso mentale che prescinde dagli eventi storici, in altri lasciandosi provocare dalle esperienze individuali e collettive quotidiane.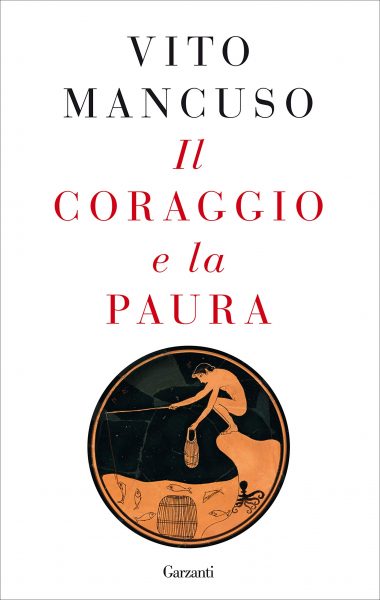
In Il coraggio e la paura (Garzanti, Milano 2020, pp. 140, euro 12,00) Vito Mancuso ci offre un esempio di riflessione del secondo tipo, provando a ragionare su alcune implicazioni esistenziali della pandemia da coronavirus in corso.
Un fenomeno del genere, almeno in Occidente, non si registrava da circa un secolo e ha suscitato le reazioni più disparate: dallo scoramento nevrotico di chi ha ritenuto prossima la fine del mondo alla sottovalutazione irresponsabile di chi ha ‘negato’ che si sia trattato di una patologia seriamente pericolosa per larghe fasce della popolazione.

L’invito dell’autore è bifronte: agli uni di “accarezzarla, la nostra paura”, di non reprimerla, dal momento che “anche lei ha bisogno di carezze e di baci, e quanto più la tratteremo con tenerezza, tanto più essa si trasformerà in intelligenza” (p. 128); agli altri di non giocare a fare i superuomini, a “diffidare di un coraggio eccessivo che può degenerare in temerarietà, aggressività, violenza” (p. 17).
In entrambi i casi, insomma, si tratta di accettare la vita con le sue polarità dialettiche: “rottura di simmetria e ricomposizione di simmetria, martello e cazzuola, forbici e colla”: “il coraggio e la paura” (p. 129) , appunto.
La ricerca di questa “armonia” al di sopra, o al di sotto, dei contrari di eraclitea memoria è possibile solo se la struttura dell’essere umano comprende, oltre la base fisica e la dimensione psichica, anche quello “spazio vuoto” (p. 96) grazie al quale “noi possiamo prendere le distanze dal nostro corpo, dalla nostra intelligenza, dalla nostra ragione, dalla nostra passione” e che possiamo chiamare “libertà” (p. 97).
Esso è la spia rivelatrice di quella dimensione antropologica “individuata dalle grandi civiltà del passato e denominata ogni volta mediante un termine che, originariamente, indicava il vento: spiritus in latino, pneûma in greco, ruah in ebraico, atman in sanscrito, tutti casi in cui il termine significa in primo luogo vento, aria libera che si muove” (p. 91).
E’ solo se esiste questa dimensione del nostro essere, e se ne abbiamo consapevolezza, che possiamo andare oltre i nostri “bisogni primari e naturalmente insopprimibili” e i nostri “desideri psichici, altrettanto reali ed esigenti” per dare corso alle nostre “più alte aspirazioni spirituali”, come hanno testimoniato, nei millenni, “Antigone, Ettore, Alcesti”; “Buddha”; “Geremia”; “Gesù”; “i partigiani, martiri della Resistenza antifascista”; “Paolo Borsellino” (pp. 91- 92).
Questo libro – visto nel suo complesso – attira ammirazione, ma, come avviene spesso con un bell’uomo o una bella donna, ciò non esclude che si possano osservare dei dettagli opinabili.
Mi limito a una sola considerazione riguardante il binomio “paura/coraggio”: la prima è uno stato d’animo, una emozione, una passione nel senso già etimologico di qualcosa che si ‘patisce’ senza volerlo e il secondo una virtù, un atteggiamento morale, che si può acquisire con l’allenamento (l’askesis dei Greci). Riterrei più convincente partire dal dato oggettivo che l’essere umano è esposto a pericoli talora minori talora gravissimi, al cospetto dei quali prova – per sua fortuna ! – paura. In quanto reazione fisiologica essa è ontologicamente ‘buona’ (apprezzabile) e moralmente neutra: come l’appetito di cibo, la sete di acqua, l’attrazione sessuale, il bisogno di essere riconosciuti socialmente e così via. 
Come assumiamo, gestiamo, questa passione primaria che è la paura? Qui, e non prima, si apre l’ambito dell’etica. Possiamo negare che il pericolo oggettivo sia oggettivo, chiudere gli occhi convinti che per ciò stesso sparirà dall’orizzonte o tuffarci dentro: questo è il vizio della ‘temerarietà’. Ad esso corrisponde il vizio opposto della ‘viltà’ di cui dà prova chi è disposto a tutto – alla fuga, al tradimento, perfino al suicidio – pur di non affrontare il pericolo oggettivo. Le due valli della temerarietà e della viltà sono separate da un monte che le sovrasta egualmente: la virtù del ‘coraggio’ che, saggiamente, discerne i rischi e li misura oggettivamente. Così concepito il coraggio può essere poco o molto, mai insufficiente o eccessivo: esso è una qualità positiva che ammette gradazioni all’interno, però, di una scala comunque apprezzabile. Se evito di affrontare un pericolo, non sono ‘poco’ coraggioso, ma vigliacco; se affronto un pericolo senza un’adeguata attrezzatura, non sono ‘molto’ coraggioso, ma un temerario. Forse per un saggio su questa tematica sarebbe stato, concettualmente, più adeguato come titolo Gestire la paura: il coraggio tra viltà e temerarietà, ma indubbiamente sarebbe risultato assai meno accattivante.

