PAGINE
Rubrica di critica recensioni anticipazioni
C’è tutta l’anima della Polizia nelle 140 pagine de “Gli ultimi carbonari“, Edizioni lavoro, il romanzo storico dell’ex Commissario Giuseppe Sergio Balsamà in libreria da febbraio prossimo.
C’è la coscienza autenticamente popolare di un’istituzione che con un notevole crescendo rappresenta da anni lo spirito profondo ed ancora non del tutto espresso della Costituzione.
Assieme ad una inedita riflessione e nel contempo all’analisi storico sociale di un’Italia che solo dall’inizio degli anni ‘80, probabilmente più per merito dell’Europa che della partitocrazia nazionale ha avviato una concreta evoluzione politica e culturale lungo la strada della democrazia compiuta, il libro fa letteralmente toccare con mano attraverso le vicende dei protagonisti quanto fossero distanti le istituzioni e i palazzi del potere dal paese reale, in che modo veniva distorta e mistificata la sovranità popolare e quanto la giustizia sociale e i diritti dei lavoratori venissero letteralmente ignorati.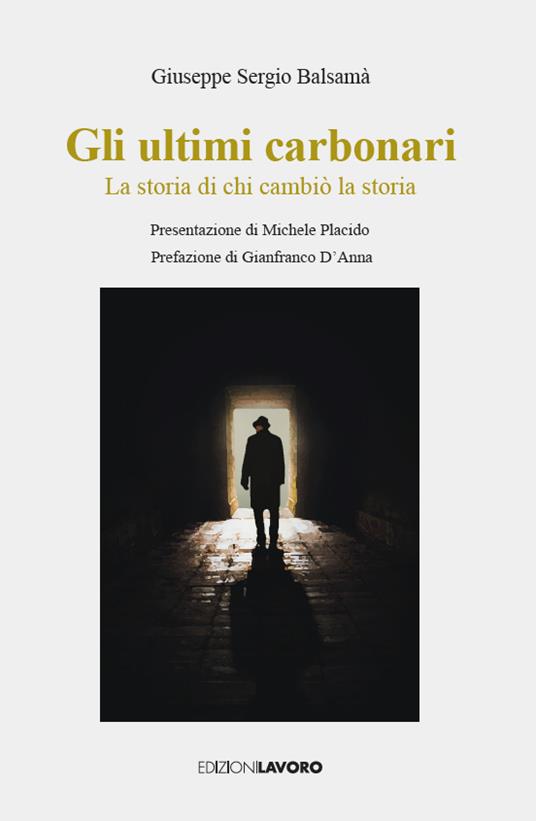
Dalle prime proteste spontanee, seguite alla morte a Milano dell’agente Antonio Annarumma e al suicidio a Torino del 19enne agente Adriano Gusella, agli incontri clandestini con l’angoscia di avere alle calcagna il famigerato Ufficio affari Riservati del Ministero dell’Interno, diretto da Federico Umberto D’Amato, all’apporto del giornalista Franco Fedeli autentico propulsore della metamorfosi democratica che avviò la smilitarizzazione e la riforma del Corpo delle Guardie di Sicurezza, il romanzo storico sprigiona un originalissimo effetto distopico.

Se l’utopia descrive i contorni di una società ideale, superiore e più giusta, le pagine de “Gli ultimi carbonari” delineano i tratti di una società orizzontalmente e verticalmente oppressiva e repressiva. Una società doppiamente ingiusta perché esercitava l’oppressione e la repressione degli ultimi attraverso i penultimi, paradossalmente tutori dell’ordine, le Guardie di Pubblica Sicurezza, strumenti e vittime della stessa ingiustizia sociale.
E’ l’immagine riflessa del Paese sulla superfice levigata e affilata della storia. Una superfice di vicende popolari che tagliano la penisola dal Sud al Nord e viceversa, innestando una consapevolezza nazionale che attraverso la determinazione a far valere la propria dignità ed avere riconosciuti i propri diritti, salda il Paese dei mille grandi comuni sbilanciati e non omogeni sotto il profilo dell’amministrazione pubblica, della giustizia, dell’assetto economico, dell’imposizione fiscale, dei trasporti e delle infrastrutture.
Il romanzo fotografa da un’angolazione tutta particolare la realtà di un’Italia ancora in guerra. Si, in guerra con se stessa, con la mentalità e gli epigoni di un regime autoritario e totalitario che per un quarto di secolo ha inquinato in profondità la società e che come tutte le malattie mortali presenta alti rischi di recidiva.
Non é un caso che prima che la riforma della Polizia possa essere varata, nel 1981, bisogna attendere l’uscita di scena di una intera generazione politica.
“La storia di chi cambiò la storia”, come specifica il sottotitolo del romanzo, contiene autentiche memorie, ricostruzioni, eventi storici.
Commovente e significativo é il racconto del primo incontro, rigorosamente clandestino, con i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil dell’epoca, fra cui Luciano Lama, al quale i “carbonari” rivolgono un preciso rimprovero: “Il suo predecessore, Di Vittorio, negli anni cinquanta e sessanta, anni di tensione fra il mondo del lavoro e la Polizia, nei comizi, che teneva di fronte agli operai, ricordava che anche i rappresentati delle forze dell’ordine sono a loro volta figli di operai e di contadini: Di Vittorio sosteneva che non bisogna confondere il poliziotto con il sistema, mentre Lei, da quando é Segretario della Cgil non ha mai seguito questa linea”.
Il riferimento al leggendario segretario della Cgil, Giuseppe Di Vittorio, contadino e partigiano, fornisce indirettamente un’interfaccia politico sindacale a quella che negli anni successivi divenne la “vulgata” di Pier Paolo Pasolini riguardante gli scontri di Valle Giulia a Roma con gli studenti. E’ la disanima pasoliniana di quegli anni sui “poliziotti figli di poveri che vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Peggio di tutto, naturalmente é lo stato psicologico cui sono ridotti per una quarantina di mille lire al mese: senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi (in una esclusione che non ha uguali); umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti (l’essere odiati fa odiare). Hanno vent’anni, la vostra età…” – scive il poeta regista che aggiunge: – “Ma prendetevela contro la Magistratura, e vedrete!…I ragazzi poliziotti che voi figli di papà, avete bastonato, appartengono all’altra classe sociale.”
Un’altra pagina di storia che viene evocata é quella evidenziata dall’intervento, al primo incontro semi clandestino al Pantheon dei neo sindacalisti delle Guardie di Pubblica Sicurezza, di un giovane funzionario che era arrivato a sue spese da Genova, Ennio Di Francesco, destinato a diventare uno dei punti di riferimento di tutto il movimento dei carbonari. “Rivolgendosi ai politici presenti, con coraggio e disinvoltura, li richiamò alle loro responsabilità: Sento ancora sulla mia spalla il peso della bara del collega Calabresi, e non mi sento di ringraziare nessuno per questo incontro; cerco ancora la ragione di quella morte e penso che voi dovreste darci qualche spiegazione. Signori parlamentari, se i miei colleghi vi ringraziano io no. Stiamo parlando di sicurezza dei cittadini e delle Istituzioni: mi sembra estremamente vergognoso e umiliante, che dopo quasi trent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, io poliziotto al servizio dei cittadini, che ho fatto un giuramento di fedeltà allo Stato, debba incontrami con dei miei rappresentanti al Parlamento, con voi rappresentanti del popolo, in maniera clandestina.”
Fra le tante ritorsioni contro la “nuova resistenza” popolare che veniva sotterraneamente condotta all’interno stesso dello Stato, viene citato il caso del cosiddetto “Margherito rosso”, il Capitano Salvatore Margherito, del secondo Reparto Celere di Padova, arrestato e deferito al Tribunale Militare nell’ agosto del 1976 per aver dichiarato di “essersi arruolato per fare il poliziotto, per garantire la convivenza sociale, e non per ritrovarsi a fare lo squadrista”. L’ ufficiale aveva denunciato come i poliziotti del suo Nucleo venissero mandati in piazza a fronteggiare studenti e lavoratori muniti di manganelli rinforzati da sbarre di piombo.
La commissione d’inchiesta del Ministero dell’Interno stabilì tuttavia la veridicità delle dichiarazioni accusatorie di Margherito, accertando che effettivamente erano stati sparati candelotti a tiro teso nei confronti dei manifestanti, in grado di uccidere, e che gli sfollagente usati contenevano tondini di ferro.








