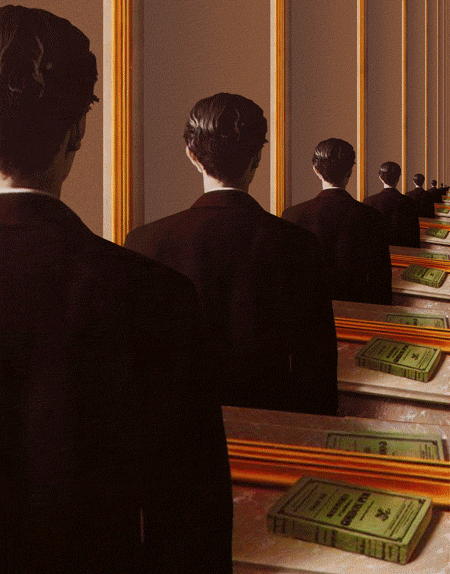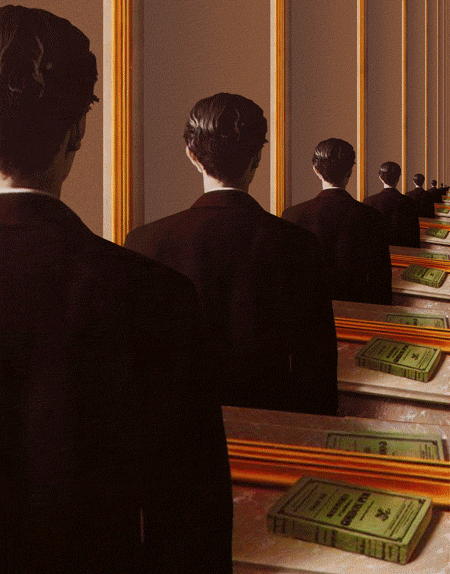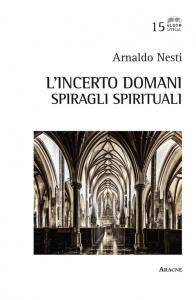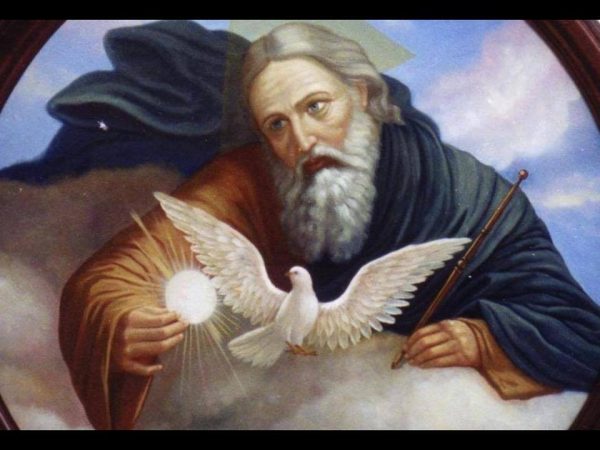Gianfranco D'AnnaFondatore e Direttore di zerozeronews.it Editorialista di Italpress. Già Condirettore dei Giornali Radio Rai, Capo Redattore Esteri e inviato di guerra al Tg2, inviato antimafia per Tg1 e Rai Palermo al maxiprocesso a cosa nostra. Ha fatto parte delle redazioni di “Viaggio attorno all’uomo” di Sergio Zavoli ed “Il Fatto” di Enzo Biagi. Vincitore nel 2007 del Premio Saint Vincent di giornalismo per il programma “Pianeta Dimenticato” di Radio1.