PAGINE
Rubrica di critica recensioni anticipazioni
by Augusto Cavadi
La Bibbia, “grande codice” (N. Frye) della cultura occidentale, ha influenzato – nel bene e nel male – i giudizi e i comportamenti di tante popolazioni, indipendentemente dalle opzioni di fede individuali.
Poiché pochissimi conoscono il greco (la lingua del Secondo Testamento) e ancor meno l’ebraico (la lingua del Primo Testamento), ciò che si apprende della Bibbia lo si legge nelle traduzioni susseguitesi lungo i secoli. Quanto ci si può fidare?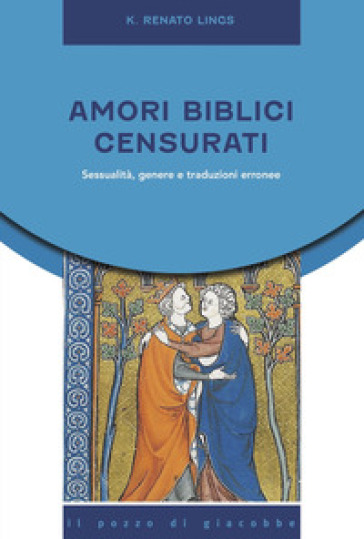
Almeno riguardo ai passi che trattano di eros e dintorni, assai poco. L’esegeta danese Kjeld Renato Lings lo dimostra, in maniera scientificamente documentata ma su un registro comunicativo leggero e dunque fruibile anche da non-specialisti, nel suo Amori biblici censurati. Sessualità, genere e traduzioni erronee (Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2023, pp. 302, euro 28,00).
Nel volume l’autore, pastore protestante ed esperto biblista, esamina diversi esempi in cui i traduttori – o per scarsa conoscenza delle lingue originarie o, più spesso, perché condizionati da pregiudizi ideologici e moralistici – hanno modificato, talora stravolto, il significato di parole-chiave e di interi brani biblici.

Un caso esemplare è costituito dal racconto del “peccato d’origine” che avrebbe segnato l’inizio di tutte le disgrazie dell’umanità: un peccato sessuale, secondo molti Padri della Chiesa e molti pittori famosi al loro seguito, ma per l’anonimo autore ebreo – invece – un peccato di orgoglio, di volontà d’autosufficienza, soprattutto di idolatria.
Un altro caso esemplare riguarda i capitoli 14,18 e 19 del libro della Genesi: la (falsa) interpretazione medievale, secondo cui le città di Sodoma e Gomorra sarebbero state “distrutte a causa dell’eccessiva propensione degli abitanti alle relazioni sessuali tra uomini e uomini” , ha comportato “conseguenze fatali per decine di migliaia di persone con relazioni omoaffettive” (p. 63).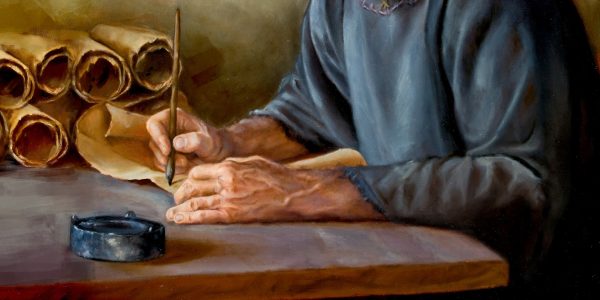
Come spiega Lings, nel Testamento ebraico “più e più volte i profeti usano il nome di Sodoma come metafora dell’arroganza, dell’abuso (di potere) e dell’oppressione dei deboli, in particolare delle vedove, degli orfani e degli stranieri” (pp. 98 – 99).
Un’intera sezione del libro è dedicata a degli “amori biblici” che, secondo l’autore, sono stati “censurati” dalle tradizioni ecclesiastiche: tra Naomi e la nuora Rut, tra Davide e l’amico Gionata, il centurione romano e il suo ragazzo, Gesù e il discepolo prediletto…
L’autore segue la traiettoria più felice fra due possibili estremismi: da una parte negare che questi personaggi siano stati rappresentati come legati da vincoli affettivi particolari (non riducibili alle ‘normali’ relazioni di parentela o di amicizia), dall’altra applicare a tali vincoli straordinari le categorie odierne di “omosessualità” (e simili).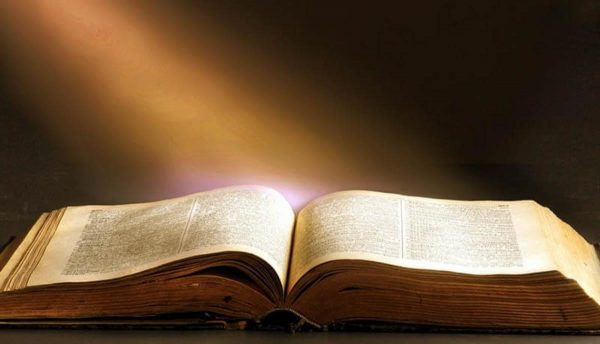
Ciò che si può affermare con certezza è che la Bibbia conosce varie declinazioni dell’amore e che solo il bigottismo moderno ha tentato (e tenta) di separare nettamente le versioni ‘legittime’ dalle ‘illegali’ e ‘peccaminose’.
Anche da questi brevi accenni, suppongo, si può intuire che il volume merita d’essere non solo letto, ma conservato in biblioteca in modo che lo si possa consultare nel tempo.



